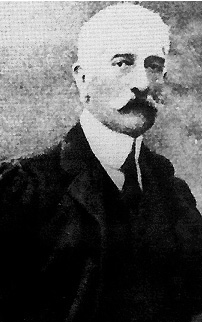I Grandi Classici I Grandi Classici Cultura
GIOSUE' CARDUCCI - SCRITTORI ROMAGNOLI - POETI ROMANI - LA LETTERATURA NAPOLETANA
IL VERISMO IN SICILIA - VOCI DI SARDEGNA - FRANCESCO DE SANCTIS - ALEARDO ALEARDI - IPPOLITO NIEVO - GIUSEPPE ROVANI - EDMONDO DE AMICIS - GIUSEPPE GIACOSA - EDOARDO CALANDRA - VITTORIO BERSEZIO - GIOVANNI CAMERANA - ARTURO GRAF - EMILIO DE MARCHI - CARLO DOSSI - GIAMPIETRO LUCINI - EMILIO PRAGA - VITTORIO BETTELONI - GIACOMO ZANELLA - VITTORIA AGANOOR - RICCARDO SELVATICO - GIACINTO GALLINA - GEROLAMO ROVETTA - ANTONIO FOGAZZARO - FERDINANDO MARTINI - GUIDO MAZZONI - ENRICO MENCIONI - GIUSEPPE CHIARINI - RENATO FUCINI - GIOSUE' CARDUCCI - OLINDO GUERRINI - ENRICO PANZACCHI - PAOLO FERRARI - SEVERINO FERRARI - GIOVANNI MARRADI - ALFREDO ORIANI - PIETRO COSSA - CESARE PASCARELLA - SALVATORE DI GIACOMO - MATILDE SERAO - LUIGI CAPUANA - GIOVANNI VERGA - FEDERICO DE ROBERTO - MARIO RAPISARDI - GRAZIA DELEDDA - SEBASTIANO SATTA
Coronavirus Covid-19.
CULTURA - LETTERATURA - L'OTTOCENTO
IL VERISMO IN SICILIA
La letteratura verista trovò nel mezzogiorno d'Italia un terreno fecondo. Essa germogliò rigogliosamente e diede i migliori frutti in Sicilia (col Verga, il Capuana e il De Roberto) mentre trascurabile apparve l'apporto letterario delle altre regioni meridionali. Il romanzo verista - che derivava dal romanzo naturalista francese di Zola e di Flaubert - Si propose di osservare la vita reale con fotografica fedeltà e con ostentata oggettività. Ma, nei suoi risultati più notevoli, finì col cadere in contraddizione con se stesso. Possiamo veramente chiamare fredda, impersonale e obiettiva un'arte, che quando non ebbe addirittura intenti di propaganda sociale e socialista, preferì comunque la rappresentazione degli aspetti più dolorosi e delle classi più umili? In realtà il verismo fu un'espressione d'arte legata alla vita economica e politica del tempo, e pur facendo parte del grande movimento positivista europeo, soddisfece al nostro bisogno di liberarci dai pregiudizi e dalle ingiustizie sociali nella vita, e dall'enfasi aulica e dalla vuotezza interiore nell'arte. Il primo cronologicamente a segnare e a sentire le nuove tendenze, verista nell'arte, fu LUIGI CAPUANA nei volumi di novelle Le appassionate e Le paesane e nel romanzo Il marchese di Roccaverdina. Abbiamo citato i libri più significativi tra i moltissimi che il Capuana scrisse, sospinto dalla versatilità dell'ingegno, dalla febbre di curiosità e di ricerca e dalla passione culturale a disperdersi in diverse attività dello spirito a volte antitetiche e opposte, dalla poesia al teatro dialettale, dal saggio critico allo studio scientifico. Oggi della spaventosa mole di lavoro del Capuana resta assai poco: alcuni tipi e caratteri delle novelle scolpiti con una vigoria che anticipa l'arte verghiana, talune intelligenti verità nel campo critico, dove il Capuana precorse il movimento crociano della sensibilità intuività contro il processo accademico della critica storica, qualche limpida pagina di letteratura per l'infanzia. Forse il merito maggiore del Capuana fu quello di aver spinto il Verga a tornare sui propri passi, ad abbandonare il genere romantico e salottiero della prima maniera e a ricercare nelle radici della terra siciliana la sostanza profonda della sua arte. VERGA stava aldilà delle dottrine estetiche. Tuttavia in quel crogiolo teorico e artistico del verismo che fu la Catania dell'ultimo ottocento, tra le ricerche sistematiche del Capuana e le speculazioni filosofiche del De Roberto, Verga non poteva restare estraneo a quelle che erano le correnti polemiche letterarie del tempo e dell'ambiente, che influirono non poco al colpo del resto della sua produzione giovanile e alla nascita dell'opera rupestre e terriera onde sorse il capolavoro dell'arte verista in Italia.Se infatti il Verga che stava per infranciosarsi nei romanzi della prima maniera non avesse fatto macchina indietro e non fosse tornato alla sua terra e alla sua vera forza istintiva di artista di razza e non si fosse rifatto il gusto di prosatore e di novelliere alle fonti classiche della nostra tradizione e sugli elementi fondamentali della tecnica manzoniana, oggi ci resterebbero le romanticherie dei Carbonari, della Peccatrice, della Storia di una Capinera, di Tigre reale, di Eva, o giù di lì; ma non avremmo La vita dei campi e Le novelle rusticane; non avremmo sopratutto I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo. Nei Malavoglia Verga narra la storia di una povera famiglia di pescatori di Aci Trezza che, per effetto delle disgrazie e della irrequietezza ambiziosa di uno dei suoi membri, si sfascia e discende ancora più in basso nella scala sociale. E' stato detto che il respiro lirico dei Malavoglia è omerico. Forse perché il vero protagonista di questo romanzo, come nell'Odissea, è il mare. Ma forse ancora, e meglio, perché Verga, come Omero, nel suo obbiettivismo narrativo condensa i più commossi sensi dell'umano dolore. La poesia è nelle stesse radici delle cose. Nessun commento esteriore, nessuna orchestrazione soggettiva degli elementi lirici. Manca la bella pagina d'effetto, l'astuzia letteraria della sinfonia descrittiva, il tono compiaciuto dell'esecuzione rara, ricercata e perfetta. Semplice e chiaro, scabro e preciso, cupo e desolato, il mondo verghiano è denso dell'imponderabile mistero della vita, senza accorgimenti e riflessioni di natura filosofica. Nessuna traccia intellettualistica, nessun residuato di schematismi ideologici, nudo, integro, compatto, il blocco di questa materia narrativa ha la incandescenza e la mobilità della vita cosmica. Anche Mastro Don Gesualdo, secondo romanzo del ciclo dei Vinti, è la storia di una disfatta. Un muratore siciliano, Gesualdo Motta, più fortunato dei Malavoglia, è giunto a conquistare attraverso sofferenze e avversità, la ricchezza, ma a che gli giova ciò? Egli finirà col morire quasi abbandonato e le sue ricchezze saranno scialacquate dalla figlia e dal genero. Rispetto ai Malavoglia, il secondo romanzo ha più impeto, più drammaticità, maggiore varietà di ambienti. Esso, per la sua tecnica costruttiva equilibrata e potente, per il suo linguaggio duttile e incisivo, per la sua intonazione epico-tragica, dimostra come lo scrittore fosse giunto all'acme della sua forza creativa. Eppure proprio in quegli anni il Verga abbandonava l'arte e la letteratura. Il suo distacco fu improvviso. Doveva completare il ciclo dei Vinti e lo lasciò incompiuto. Mancavano ancora tre volumi: La duchessa di Leyra, L'Onorevole Scipioni e L'Uomo di Lusso. Si è pensato ad una crisi di coscienza d'arte, a un essiccamento di vena, ad una difficoltà della materia, ad una stanchezza senile. Pare che lo stesso Verga esponesse ad amici gli ostacoli che si opponevano all'intuizione e alla ricostruzione del mondo aristocratico, dove il convenzionalismo, sovrapponendosi alla natura impedisce il fissaggio dei caratteri. E sarà anche vero. Tuttavia si stenta a credere che un uomo giunto alla maturità e al possesso assoluto dei mezzi creativi si areni di colpo, dinanzi ad impedimenti di questo genere; e proprio dinanzi ad un mondo che da giovane (e spesso felicemente) ha reso negli ancor vivi personaggi di Tigre reale, di Eva, del Marito di Elena; dinanzi ad un mondo, infine, che è già per certi lati, mirabilmente colto in alcuni capitoli del Mastro Don Gesualdo. No, il Verga non voleva confessare a sé medesimo, le profonde, remote cause, che lo avevano allontanato dall'arte. Il senso morboso, della dignità e del riserbo è un po' nell'antico retaggio della nostra razza. Il siciliano con tutte le varianti inevitabili è tipicamente cupo, restio, impressionabilissimo, egocentrico. Sotto le apparenze morbide, cedevoli, remissive, c'è un'irriducibile fierezza che lo fa muro. Il siciliano è per lo più, un testardo timido; ed ha dei testardi lo sprezzante silenzio e dei timidi le audacie inconsulte. Il mondo verghiano è popolato di personaggi di cosiffatta natura: gente tenace e caparbia, capace di soffrire e tacere. Anche la rinunzia è la forma di una segreta superbia. I Vinti di Verga non sono naufraghi abulici della vita, sono invece rudi ed ostinati superstiti di una battaglia perduta. Questi personaggi riflettono il carattere dello scrittore. Il siciliano tace ma non dimentica, Verga tacque il suo dolore e il suo risentimento, quando si vide sacrificato dinanzi alla facile gloria conquistata da altri (vedi d'Annunzio) con forme e modo, che alla sua esigenza spirituale e creativa dovevano apparire insinceri e intellettualistici. Verga non dimenticò l'onta subita quando, dopo un ventennio di silenzio e d'oblio, l'Italia parve ravvedersi dell'errore. Un nordico, probabilmente, avrebbe reagito, polemizzato, discusso, il siciliano rientra in se stesso e si corazza di sdegno. Il fenomeno è maggiormente spiegabile se si considera che il Verga non fu un letterato, nel senso professionale della parola, sibbene un artista di nativa e medianica genialità. Il che giustifica meglio il fatto che egli, abbandonata l'arte non sia rimasto impigliato nel vizio letterario, come avviene a quegli scrittori in cui, estinto lo stimolo creativo, permane l'abitudine del mestiere. Legato da fraterna amicizia al Verga fu anche FEDERICO DE ROBERTO, nato a Napoli ma vissuto quasi costantemente a Catania e perciò considerato, a ragione, come siciliano. Ebbe il De Roberto viva dottrina scientifica e storica e gusto di stilista e di narratore. Scrupoloso, metodico, esattissimo e geniale ad un tempo, negli argomenti prescelti portò sino all'inverosimile la paziente precisione dei documenti e delle ricerche. L'opera maggiore del De Roberto è il romanzo I viceré, nel quale è ricostruita fantasiosamente, e in alcuni dettagli cronisticamente, la vita della Catania delle ultime propaggini spagnolesche, dell'avvento nuovo che afferma i diritti dell'intelligenza, i valori dello spirito e il trionfo dell'italianità. E' un'opera d'arte di colore locale, dove gli elementi etnici e ambientali hanno un tipico rilievo tutto isolano che dimostra quanto ormai il De Roberto avesse assorbito dalla terra, dalla storia e dalla natura siciliana. Mentre nel campo della narrativa la Sicilia si poneva all'avanguardia del movimento letterario italiano, in poesia essa rimaneva fermamente ancorata ad una forma classicista o neoromantica in cui il frequente contenuto naturalistico o addirittura socialistico non riusciva ad esprimersi efficacemente, come può osservarsi soprattutto in Giuseppe Aurelio Costanzo e in MARIO RAPISARDI. Tuttavia sarebbe ingiusto l'affermare che il Rapisardi fu sempre manierato e prolisso, pomposo e magniloquente, arcaico e arcadico, victorughiano e frugoniano. Se è vero che la materia scelta e la natura dei poemi e il tono epico, didascalico e gnomico della sua arte lo ricacciarono nelle antiche forme e nell'usata fraseologia, non bisogna dimenticare che quando si ritrovò di fronte alla sua profonda ed intima commozione umana, egli, esprimendosi con più nuda schiettezza, riuscì a darci un'eco della sua naturale voce. In molti squarci del Giobbe, in alcune delle Poesie religiose, e in taluni Poemetti, il mistero della creazione non è più indagine scientifica, la natura non è semplice sfondo pittorico, e il canto stesso non è più sonoro rifacimento di altre musiche ma volo della fantasia nei cieli del finito e dell'infinito e grido sgomento dell'anima dinanzi agli abissi dell'Inconoscibile.